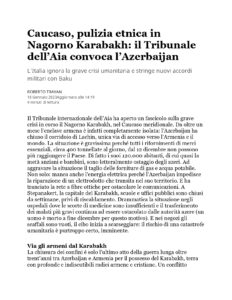Caucaso, pulizia etnica in Nagorno Karabakh: il Tribunale dell’Aia convoca l’Azerbaijan (La Stampa 18.01.23)
Roberto Travan
Il Tribunale internazionale dell’Aia ha aperto un fascicolo sulla grave crisi in corso il Nagorno Karabakh, nel Caucaso meridionale. Da oltre un mese l’enclave armena è infatti completamente isolata: l’Azerbaijan ha chiuso il corridoio di Lachin, unica via di accesso verso l’Armenia e il mondo. La situazione è gravissima perché tutti i rifornimenti di merci essenziali, circa 400 tonnellate al giorno, dal 12 dicembre non possono più raggiungere il Paese. Di fatto i suoi 120.000 abitanti, di cui quasi la metà anziani e bambini, sono letteralmente ostaggio degli azeri. Ad aggravare la situazione il taglio delle forniture di gas e acqua potabile. Non solo: manca anche l’energia elettrica perché l’Azerbaijan impedisce la riparazione di un elettrodotto che transita nel suo territorio. E ha tranciato la rete a fibre ottiche per ostacolare le comunicazioni. A Stepanakert, la capitale del Karabakh, scuole e uffici pubblici sono chiusi da settimane, privi di riscaldamento. Drammatica la situazione negli ospedali dove le scorte di medicine sono insufficienti e il trasferimento dei malati più gravi continua ad essere ostacolato dalle autorità azere (un uomo è morto a fine dicembre per questo motivo). E nei negozi gli scaffali sono vuoti, il cibo inizia a scarseggiare: il rischio di una catastrofe umanitaria è purtroppo certo, imminente.
Via gli armeni dal Karabakh. La chiusura dei confini è solo l’ultimo atto della guerra lunga oltre trent’anni tra Azerbaijan e Armenia per il possesso del Karabakh, terra con profonde e indiscutibili radici armene e cristiane. Un conflitto dimenticato che ha causato fino ad ora quasi 40.000 morti e oltre un milione di sfollati. A dicembre decine di azeri avevano bloccato la frontiera inscenando una protesta ecologista. Per gli Ombdusmen di Armenia e Karabakh si trattava in realtà di provocatori tra cui «numerosi appartenenti ai servizi speciali di sicurezza azeri e simpatizzanti dei Lupi grigi, formazione terroristica dell’estrema destra turca». A inizio dicembre la conferma: gli “ecologisti” hanno abbandonato il blocco e al loro posto, a fronteggiare l’inerte contingente russo schierato da due anni a protezione del valico, sono arrivati i militari inviati da Baku, la capitale azera. Infine le parole dello stesso presidente Ilham Aliyev, il 10 gennaio: «Coloro che non vogliono diventare cittadini dell’Azerbaijan possono farlo: il corridoio di Lachin è aperto, nessuno gli impedirà di andarsene». In realtà il passaggio è chiuso, gli abitanti del Karabakh sono letteralmente in trappola.
Rischio pulizia etnica. «Gli azeri stanno violando tutte le leggi internazionali a tutela dei civili nelle zone di guerra». A lanciare l’allarme, un mese fa, erano stati i Difensori dei diritti umani di Armenia e Karabakh. «È in atto una vera e propria strategia per provocare la fuga della popolazione armena e lo spopolamento del Paese» avevano denunciato. Nel loro dossier «gli attacchi alle infrastrutture civili, l’interruzione sistematica di gasdotti e acquedotti, le incursioni nei villaggi pacifici per mettere in ginocchio l’agricoltura e l’economia». Anche «le campagne di propaganda e disinformazione per terrorizzare gli abitanti». Infine, l’appello: «È in corso un’autentica pulizia etnica, il mondo deve intervenire».
Le ambiguità della Russia. Neppure la forza di interposizione russa – schierata in base agli accordi tra Armenia, Azerbaijan e Russia dopo la Guerra dei 44 giorni – è riuscita a rompere l’isolamento del Karabakh. Peggio: Mosca è accusata di aver «consentito il blocco dei confini e di non aver protetto l’Armenia dai ripetuti attacchi dell’Azerbaijan» accusa Karen Ohanjanyan, attivista e fondatore a Stepanakert del Comitato Helsinki 92, organizzazione non governativa per i diritti umani. Forse per questo motivo il premier armeno Nikol Pashinyan la scorsa settimana ha annullato le esercitazioni previste dal Trattato di sicurezza collettiva, il Patto militare che lega alcuni Paesi dell’ex Unione Sovietica. Un legame certamente opaco quello tra Mosca e Yerevan. Perché la Russia, dal 1995 in Armenia con un folto contingente, è da sempre uno dei principali fornitori di armi dell’Azerbaijan. Anche di gas poi triangolato da Baku in Europa, in barba alle sanzioni per l’invasione dell’Ucraina.
Il Karabakh nelle mani di un oligarca russo. Protegge l’operato della forza di peacekeeping inviata da Mosca il premier del Karabakh Ruben Vardanyan. Ci prova tentando di spostare l’attenzione sulla comunità internazionale: «Perché le Nazioni Unite, la Francia e gli Stati Uniti non fanno qualcosa? Perché l’Occidente non impone sanzioni all’Azerbaijan?». Vardanyan, noto filantropo e oligarca russo (con cittadinanza armena), è sempre più contestato per i suoi altrettanto noti e stretti rapporti con il Cremlino. Amicizie che gettano più di un’ombra sul suo operato. «L’ascesa e il ruolo di Vardanyan sono in diretto contrasto con l’impegno decennale nella costruzione di istituzioni democratiche in Karabakh», ha dichiarato l’analista Richard Giragosian. Ma l’oligarca russo “prestato” – secondo i suoi sempre più numerosi detrattori – alla causa della piccola Repubblica de facto, glissa e continua a spingere su un improbabile dialogo con gli azeri. Ma soprattutto non è intenzionato a rinunciare alla poltrona di premier, notizia data per certa a Yerevan dove circola insistentemente da settimane. «Non mi dimetterò. Anche le possibili dimissioni del Presidente o lo scioglimento del Parlamento sono inaccettabili. Dobbiamo riunire tutti i nostri sforzi per superare questa orribile situazione» ha dichiarato.
L’Armenia ha le mani legate. L’Armenia, madrepatria del Karabakh (sebbene non ne abbia mai riconosciuto l’indipendenza) ha le mani legate dopo la pesante sconfitta subita due anni fa nella Guerra dei 44 giorni. E il suo premier Nikol Pashinyan sa perfettamente di essere con le spalle al muro. È immobilizzato in primis dall’ingombrante alleato russo che, impantanato militarmente in Ucraina, non può permettersi un nuovo fronte nel Caucaso dove ha già molti conti in sospeso per l’occupazione dell’Abcasia e dell’Ossezia del Sud, territori strappati alla Georgia; è intimorito dalla Turchia armenofoba di Erdogan intenzionata a portare a termine il genocidio armeno (mai riconosciuto) iniziato un secolo fa dall’Impero Ottomano, ecatombe per un milione e mezzo di vittime innocenti; attaccato sul campo dall’Azerbaijan della famiglia Aliyev, al potere da oltre trent’anni, intoccabile per i suoi grassi affari con l’Europa affamata di gas; indebolito dalle proteste popolari agitate dalla débâcle bellica e diplomatica, certo, ma non meno dal peso della crisi sociale ed economica in cui da tempo è sprofondato il Paese.
Le reazioni della comunità internazionale. I ministri degli Esteri di Armenia e Nagorno Karabakh un mese fa avevano ammonito con chiarezza la comunità internazionale: «L’assenza di una reazione adeguata all’aggressione azera potrebbe causare nuovi tragici sviluppi». Ne ha discusso il Consiglio di Sicurezza dell’Onu il 20 dicembre. E l’indomani – dopo il decesso di un uomo rimasto senza cure a causa dei confini bloccati – la Corte europea dei Diritti umani ha intimato agli azeri di consentire l’evacuazione dei pazienti più gravi. E l’Italia? Il 12 gennaio il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato a Baku il presidente Aliyev per «discutere – come ha sottolineato in una nota la nostra ambasciata – di stabilità regionale e nuove prospettive di collaborazione». Tradotto: nuovi affari in campo militare e gas a volontà. Ma non una parola sulla grave crisi – regionale e umanitaria – che sta soffocando, giorno dopo giorno, il Nagorno Karabakh. L’appello degli armeni è stato fortunatamente raccolto dal Tribunale internazionale dell’Aia, il principale organo di giustizia delle Nazioni Unite: la Corte ha convocato Azerbaijan il 30 gennaio per «la richiesta di provvedimenti legati all’applicazione della Convenzione internazionale contro qualsiasi forma di discriminazione razziale». Se non sarà troppo tardi.