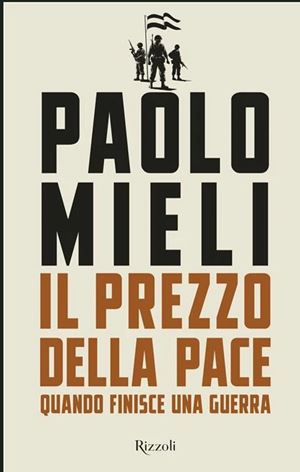Dopo incontri tra Armenia, Azerbaijan e Turchia, cresce l’ottimismo per un trattato di pace entro il 2026. Yerevan spera nella riapertura del confine con Ankara. Pashinyan punta a risultati concreti per rafforzare la sua fragile posizione politica
Dopo il tanto atteso incontro tra il premier armeno Nikol Pashinyan e il presidente azerbaijano Ilham Aliyev, ospitato lo scorso 8 agosto alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, cresce l’ottimismo sulla possibilità che Yerevan e Baku concludano un trattato di pace, da tempo annunciato, entro meno di un anno. Allo stesso tempo, sembra emergere un rinnovato slancio su un fronte parallelo, quello della normalizzazione delle relazioni tra Armenia e Turchia.
Lo scorso 12 settembre, Rubin Rubinyan e Serdar Kiliç, inviati speciali dell’Armenia e della Turchia per la normalizzazione delle relazioni tra i due paesi, si sono incontrati a Yerevan. È stato il sesto incontro dei due diplomatici da gennaio 2022 e il primo a svolgersi nella capitale armena.
Le visite dei funzionari turchi di alto rango in Armenia non sono certo una novità – già nel 2008 l’allora presidente della Turchia Abdullah Gül si era recato in Armenia – però la tempistica dell’ultimo incontro è tutt’altro che irrilevante.
Da decenni ormai gli sforzi per normalizzare i rapporti tra Armenia e Turchia si intrecciano strettamente con la questione delle relazioni tra Armenia e Azerbaijan. Il confine tra Armenia e Turchia è stato chiuso nel 1993 dopo che le forze armene hanno conquistato Kelbajar, insieme ad altre sei regioni attorno al Karabakh. Da allora, Ankara ha sempre affermato chiaramente che l’apertura del confine e la normalizzazione delle relazioni con Yerevan non saranno possibili fino a quando anche Azerbaijan e Armenia non faranno progressi analoghi nelle loro relazioni bilaterali.
Parlando con i giornalisti dopo l’incontro Kiliç-Rubinyan, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan si è detto fiducioso che il trattato di pace tra Yerevan e Baku, finalizzato a marzo e sottoscritto ad agosto, possa essere concluso nella prima metà del 2026. Ne seguirebbe immediatamente la normalizzazione delle relazioni, e quindi anche l’apertura dell’intero confine tra Armenia e Turchia. Naturalmente, Yerevan auspica che il confine possa essere riaperto prima, sperando di poter beneficiare di nuove rotte commerciali.
In passato, qualsiasi apertura del confine si è rivelata un gesto meramente simbolico. Nel 2023, uno dei due confini dell’Armenia con la Turchia è stato temporaneamente riaperto per permettere la consegna di aiuti alla Turchia colpita dal terremoto. Poi all’inizio di quest’anno, lo stesso è accaduto per consentire il trasporto di aiuti umanitari dall’Armenia alla Siria. Già nei primi anni ’90, durante la guerra del Karabakh, la Turchia aveva consentito il trasporto temporaneo di grano in Armenia, a quel tempo alle prese con una grave carenza di cereali.
Al termine dell’incontro dello scorso 12 settembre tra l’inviato speciale armeno e il suo omologo turco, le due parti hanno diffuso un comunicato stampa di una sola pagina, ribadendo il proprio impegno per promuovere la normalizzazione delle relazioni bilaterali. Nel comunicato si parla del ripristino della ferrovia Kars-Gyumri, a lungo inattiva, dell’apertura del confine a cittadini e diplomatici di paesi terzi, ma anche dell’intenzione di rafforzare gli scambi accademici e introdurre ulteriori voli diretti. Ci sono già voli tra Yerevan e Istanbul, introdotti per la prima volta a metà degli anni ‘90.
A fine agosto, Pashinyan si è recato in Cina attraversando lo spazio aereo dell’Azerbaijan ed è stato fotografato mentre parlava allegramente con Aliyev al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Anche le loro mogli, Anna Hakobyan e Mehriban Aliyeva, sono state fotografate insieme ad Emine Erdoğan, moglie del presidente turco. Queste immagini, senza precedenti, sono state ampiamente condivise online e, a quanto pare, create appositamente per inviare un segnale positivo ai cittadini dei tre paesi da tempo ormai abituati all’ostilità.
La normalizzazione delle relazioni comporta però un prezzo politico da pagare. A settembre, il governo armeno ha annunciato che l’immagine del Monte Ararat, noto in Turchia come Monte Ağrı, verrà rimosso dai timbri di frontiera armeni a partire da novembre. La decisione, da molti interpretata come un tentativo di evitare simboli in cui Ankara vede rivendicazioni territoriali, ha provocato una valanga di critiche dell’opposizione armena. Alcuni hanno osservato che la decisione è giunta il giorno prima della visita di Kiliç a Yerevan. Pashinyan ha negato qualsiasi collegamento tra i due eventi.
Qualunque sia la ragione, la decisione di rimuovere l’immagine del Monte Ararat è l’ennesima prova della delicata operazione di bilanciamento portata avanti da Pashinyan, il cui destino politico è strettamente legato alla sua “agenda di pace”.
Con l’avvicinarsi delle elezioni politiche, fissate a giugno 2026, il premier armeno, alle prese con un calo di consensi inaudito, spera di compiere progressi tangibili in termini di integrità e connettività regionale. Le forze di opposizione hanno già iniziato a presentare le concessioni fatte da Pashinyan come un tradimento dell’identità nazionale.
Ironicamente, era stato il governo guidato dal partito dell’ex presidente armeno Serzh Sargsyan – oggi la seconda forza di opposizione all’Assemblea nazionale armena – a tentare per primo di normalizzare le relazioni con Ankara. I protocolli di Zurigo del 2009 erano falliti a causa della resistenza politica sia in Armenia che in Turchia, ma anche per via dei disaccordi sulla storia e sulla risoluzione del conflitto con l’Azerbaijan.
Ci sono però sempre state relazioni informali tra Armenia e Turchia. I marchi turchi, ad esempio, sono facilmente reperibili a Yerevan e molti armeni lavorano illegalmente in Turchia.
I prossimi mesi saranno cruciali. Se da un lato Yerevan si dice pronta a firmare immediatamente un trattato di pace con Baku, quest’ultima continua a chiedere che la Costituzione armena venga modificata. La Turchia invece insiste sulla necessità di aspettare un accordo di pace tra Baku e Yerevan prima di normalizzare le sue relazioni con l’Armenia. Ad ogni modo, i due processi potrebbero convergere nella prima metà del 2026, in vista delle elezioni armene.
Per Pashinyan, la posta in gioco è alta. Considerando che la sua popolarità è crollata drasticamente dal 2018, il premier armeno spera di assicurarsi un futuro politico firmando un accordo di pace con Baku.
Per Aliyev ed Erdoğan, il successo del processo di normalizzazione delle relazioni con l’Armenia significherebbe le possibilità di espandere la propria influenza nella regione e di aprire nuove opportunità economiche. Per Washington, invece, rappresenterebbe un inaspettato trionfo diplomatico, in un momento, come quello attuale, in cui gli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina vacillano. Dopo decenni di conflitto, anche un cauto ottimismo segna un passo avanti.
Vai al sito