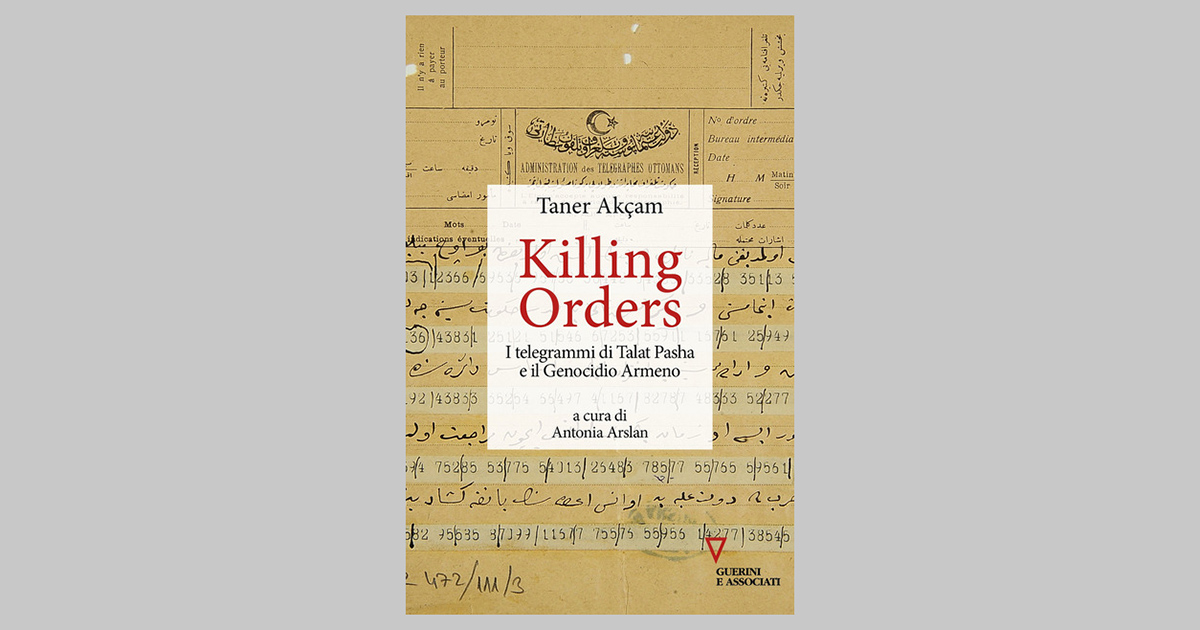“Il chicco acre della melagrana”: tra Roma e il Medioriente, nell’autobiografia di Giorgio Kevork Orfalian, 70 anni di storia armena ed europea (Vivereroma 28.12.20)
Ma la narrazione parte da prima, da quell’incredibile decennio 1910-’20 che vede, soprattutto, lo tsunami della Grande guerra: che, nell’Impero Ottomano, significa l’inizio del ”Medz Yeghern”, quel genocidio del popolo armeno che durerà, tra alterne vicende, sino ai primi anni’ 20.
Giorgio Kevork Orfalian nasce nel 1950 a Tripoli di Libia, figlio di Dikran Orfalian, armeno (di origini in parte anche palestinesi) che ha combattuto, come carrista, nella mitica VIII Armata britannica nel ’42-’43, e da Harshaluis Devruscian, di famiglia armena che, in passato, ha vissuto direttamente il dramma del “Medz Yeghern”, con una pazzesca “anabasi”, da deportati, da Aleppo sino a Tripoli. Andato, a 13 anni, a studiare al Collegio armeno “Moorat Raphael” di Venezia, gestito dai severi padri melchitaristi, Giorgio si diploma nel 1969; e come in un film, arriva in aereo a Fiumicino, per prendere il volo per Tripoli, proprio il 1 settembre 1969. Cioè quando, a Tripoli, il colonnello Gheddafi ha trionfato nel golpe, d’impronta nasserista e panaraba, contro il vecchio (e troppo filoccidentale) re Idris I. Bloccato a Roma, il giovane è costretto a una lunga “gavetta” esistenziale e lavorativa: salendo gradualmente la scala sociale grazie a uno spiccato senso pratico-economico e a un pizzico di fortuna. Seguirà, sempre entro l’anno e parallelamente ai lavori piu’ disparati (da benzinaio a venditore di bibite allo stadio), l’iscrizione alla “Sapienza” (prima a Medicina, poi a Psicologia). E’ il 1972, quando al giovane Giorgio capita addirittura d’incontrare – per un possibile provino cinematografico – Pier Paolo Pasolini, alla ricerca di comparse per il suo prossimo film (“I racconti di Canterbury”?).
Nel frattempo, oltre a pensare a un lavoro migliore (come rappresentante di commercio per la Libia nel settore calzature), Orfalian non dimentica la causa del suo Paese (a quell’epoca, non ancora Stato indipendente, ma Repubblica armena membro dell‘Unione Sovietica). Sempre nei primi annì ’70, a Roma, ha modo d’incontrare e intervistare Armin Tehophil Wegner, l’intellettuale tedesco che nel 1915, trovandosi, come militare paramedico, nell’Impero ottomano, aveva avuto modo d’assistere al massacro degli armeni, documentandolo segretamente con storiche fotografie. Da Wegner, giornalista e scrittore controcorrente, nel Primo dopoguerra autore delle prime denunce ufficiali del genocidio armeno (tra i 200.000 e 1.800.000 morti, secondo le stime correnti), che morirà poi, temporaneamente dimenticato dalla Germania, sempre a Roma nel 1978, Giorgio ha in regalo proprio alcune di quelle storiche foto. E’ un genocidio, questo degli armeni, che i turchi tuttora si ostinano a negare, attribuendo tale strage a una guerra civile nel caos del primo conflitto mondiale, accompagnata da carestia e malattie.
Ma il momento in cui Orfalian entra piu’ direttamente (e drammaticamente) a contatto con la storia del’900 è nel 1977 – ’78. Quando un maledetto errore del quotidiano “Il Tempo”, ripreso purtroppo da altre testate estere, soprattutto turche (un articolo citante Giorgio e altri connazionali viventi a Roma come pericolosi terroristi indipendentisti armeni) mette in moto un meccanismo infernale. In cui lui incappa quando, nell’estate del ’77, per leggerezza decide di andare in vacanza in Iran passando proprio da Grecia… e Turchia. Quel che gli accade in seguito, è esattamente identico alla vicenda di Bill Hayes, il ragazzo americano la cui storia (1970, pochi anni prima) è nota a tutto il mondo grazie al cult.-movie di Alan Parker “Fuga di mezzanotte”: il fermo alla frontiera turca, l’arresto, l’incubo della detenzione in un carcere turco, senza alcuna possibilità di comunicare, per lungo tempo, con la sua famiglia, fra torture fisiche e psicologiche e condizioni igieniche inimmaginabili. Una discesa agli inferi che per il giovane professionista armeno si interromperà solo a fine aprile del ’78, con l’assoluzione (ma solo per insufficienza di prove) dalla gravissima accusa di attentato alla sicurezza dello Stato turco.
Seguiranno il ritorno a Roma, la ripresa del lavoro (con importanti iniziative commerciali, stavolta in proprio da imprenditore, un po’ in tutto il Vicino oriente, anche durante la Guerra del Golfo del 1991), due matrimoni. E la partecipazione come volontario, insieme al leader indipendentista armeno Monte Melkonian (che morirà poi nel 1993), alla prima guerra tra Armenia (dal ’91 indipendente, col crollo dell‘URSS) e Azerbaigian per l’indipendenza del Nagorno-Karabakh, o, meglio, Artsakh. L’enclave armena (abitata quasi totalmente da armeni) nel territorio azero, da sempre in lotta per l’indipendenza dall’ Azerbaigian, per il cui destino, dal 1992, si combatte un interminabile conflitto armeno-azero, tra Yerevan e Stepanakert, da un lato, e Baku’ dall’altro (sino al terzo conflitto, iniziato a settembre 2020 e interrotto, a novembre scorso, dal temporaneo accordo di pace raggiunto grazie alla mediazione russa). A maggio 1992, Kevork Orfalian è tra i combattenti che strappano agli azeri Shushi, unica città dell’Artsakh con forte presenza azera.
Una vita che, senza esagerare, si presterebbe – come lo stesso Autore confessa di desiderare in chiusura del libro – ad essere tradotta in un film.